Autodafé
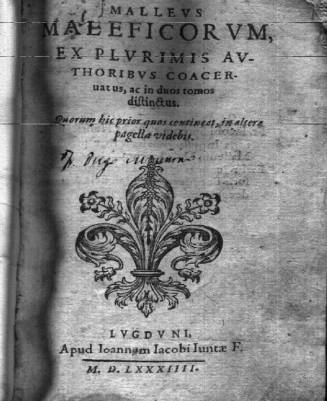
Ci sono cose che scrivo a cui tengo particolarmente.
Magari non sono le migliori, magari non hanno quel quid che le rende speciali, o indimenticabili.
Ci sono cose che quando si scrivono sono come un risultato di un’operazione chirurgica (non matematica).
Sono parole che nascono sulla pelle, mi entrano dentro, mi circolano come sangue, a volte ristagnano in qualche organo vitale, lo comprimono, lo fiaccano, lo infiammano, o lo anestetizzano. Oppure lo fanno essere iperattivo, quasi a bruciarlo.
Poi avviene l’operazione. Lo strappo. O la dissoluzione.
Non è che poi si guarisca.
Non è una malattia.
Alla fine però queste parole vengono fuori, nel loro modo, per dire ciò che hanno da dire al mondo, per farsi ascoltare da tutti. Esse non hanno pretesa di essere comprese. Esse dicono liberamente e altrettanto liberamente desiderano essere ascoltate. Il loro modo è uno stile depurato. Faticosamente. Distillato.
Sono parole che sono passate attraverso un alambicco, goccia dopo goccia, seguendo un processo lento.
Sono sensazioni che parlano e le sensazioni hanno tutte le lingue del mondo per parlare.
La mia lingua vuol essere letta.
E quando dico letta voglio dire pronunciata. E’ un piccolo consiglio questo, non è la chiave di lettura. Non l’unica almeno.
Il resto, il messaggio, vorrei dire, è quasi secondario. Mi importa la sensazione. Come fare a spiegar meglio?
Dilemmi, parole ermetiche non mi appartengono, se non come meri espedienti per esprimere la sottile indeterminatezza di ciò che mi accade e che in qualche modo mi ispira.
Voglio dire che io mi lascio sfiorare, prima di immergermi dentro.
E quando mi immergo vivo. E non scrivo.
Ora posso dare sensazione diverse a chi mi legge. E’ il mio intento, compreso il provocare repulsione o la sensazione di sentirsi in una sala d’attesa di un centro d’igiene linguistico mentale.
Però ecco, detto così, mi par proprio mi si dia della pazza. E la cosa mi provoca un certo fastidio.

Mah… esiste un modo di scrivere le sensazioni che non ricorra all’intrinseca musicalita’ necessaria delle “parole lette a voce alta”, per manifestarsi appieno?
Qui non si parla di manuali d’impiego, di formule matematiche, di e-book sterili e veloci: qui si parla di musica e pensieri.
Ti leggo come cantar una canzone, ti leggo come suonar una musica non mia, a volte con la difficolta’ che si incontra nel suonare uno spartito in prima lettura, rileggendo per trovar la miglior diteggiatura… per me.
Riguardo al fastidio di esser presi per pazzi, beh, e’ un rischio che si corre, essendo pubblici i nostri scritti…
… ma attenta: puoi sempre “guardare” chi lo fa con un sorriso e pronuciare le magiche parole, a mo’ di spiegazione:
” Queste sono le mie mani, questa la mia faccia.”
Io spesso leggendo i tuoi scritti ho tante sensazioni che emergono…la prima è “non ho capito”..”fammi rileggere”…e così altre 3 o 4 volte…
ed è solo quando lascio perdere il capire il significato e leggo le parole una per una che allora capisco….o meglio leggo e chiudo gli occhi…e quel che rimane è un colore, uno stato d’animo, una parola che mi ha colpito più di altre…hai lasciato un segno..hai espresso le tue sensazioni nella tua lingua…che non è la mia, è solo diversa, e come dici tu le sensazioni hanno tutte le lingue del mondo per parlare.
Mio dio non ti riconosco più ma dovè finita la sana ironia…. dove è finito lo spirito che tracima sopra le righe ai scritto un post inutile per quel poco che ti conosco so che non sei pazza… era un sana metafora ironica ma forse ti sei inquadrata e l’ironia si è persa…
forse prima di scrivere questo post era meglio una risata e poi non scriverlo comunque porgo le mie scuse se quella ironia è stata colta in maniera sbagliata….
comunque mi sepre piaciuto come scrivi, se no non scriverei commenti ma solamente lascerei perdere perche saresti indifferente ma non è cosi.
per cio cara amica poetessaRossa di rabbia fai affiorare il tuo umor e vedrai che una risata certe volte vale più di mille parole…
ciao
a presto ” ti aspetto nella stanza 113 del centro d’igene mentale e linguistico prego di bussare tre volte prima di entrare”……
la vita è un tango
e il decalogo di Pennac dove lo mettiamo, eh?
besos
🙂